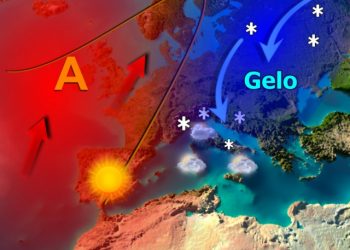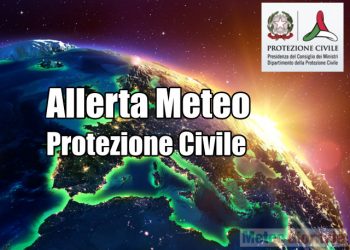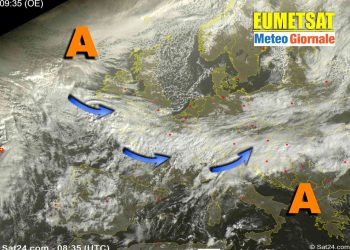Non vorrei annoiare i lettori del MTG con queste teorie a volte poco comprensibili, ma chiudere questo discorso attraverso un “itinerario” che ha così condizionato la scienza moderna.
Quando si parla di sistemi, a noi tutti noti, non si può altro che riferirci alla meccanica impressa da Galileo.
Non volendo entrare nel dettaglio storico/illuministico, si possono chiaramente osservare degli elementi di grande valore introdotti da Galileo nel corso del secolo XVII. Tutte teorie che seguono strettamente una base sperimentale.
Negli ultimi decenni il nome di Galileo è apparso con una certa frequenza, da parte dei divulgatori ecclesiastici, ottenendo una rivisitazione del Suo pensiero che per molti secoli è stato “affossato” dalla stessa Chiesa Cattolica Romanica Apostolica.
Lo scienziato pisano, basandosi sulle osservazioni ottenute con gli allora disponibili mezzi da lui stesso ideati, rese noto “al mondo di allora” che non v’era perfetta sfericità dei corpi celesti, giungendo alla conclusione, teoria eliocentrica, in contrasto netto con quella geometrica di ispirazione tolemaica.
Questa fu una delle cause principali per cui, la Chiesa di allora, fece richiesta di abiura.
In realtà lo scienziato pisano non fu solo ed esclusivamente uno studioso degli astri e del sistema solare, ma anche attento osservatore, rigorosamente probatorio, circa le dinamiche atmosferiche; introducendo un “terremoto” scientifico inerente lo studio ed osservazione di un metodo che venne definito in seguito come: “metodo sperimentale”.
Gli stessi studi di Galileo riferiti alla dinamica di semplici sistemi meccanici “lineari” (equazioni), portò alla luce, per la prima volta, i limiti che un sistema mostra nella sua naturale incompletezza.
Semplici ed elementari: causa/effetto, che davano una diversa esposizioni dei piani rotanti su di un asse verticale e dell’accelerazione, per via della gravità, di un corpo, con maggior peso specifico, rispetto ad un altro in considerazione dell’elemento: “forza di gravità”.
Quindi il primo passo di Galileo fu verso una moderna concezione scientifica tale da poter indurre ad immaginare che certi eventi, costruiti appositamente da noi uomini, quindi mai sperimentati o introdotti nella natura, possono presentarsi sotto forme molto difformi rispetto al pensiero allora consolidato.
Ecco che Galileo enuncia spesso le “sensate esperienze” (anticamera delle sperimentazioni in laboratorio), soprattutto per le osservazioni da Lui ideate e condotte.
Una, infine, delle peculiari diversità del “vecchio pensiero aristotelico” e quello Galileiano , stava proprio nell’introdurre una prova finalizzata onde mettere un risultato, uno schema “teorico” esplicativo, circa un sistema complesso che viene studiato/osservato.
Altro elemento che marca una netta distinzione tra le “due visioni” è l’importanza che riveste l’analisi quantitativa dei problemi, calcoli, per mezzo dell’uso “puro” della matematica. In effetti Egli pensò, precorrendo i secoli, che il “grande libro della natura” fosse fonte ed ispirazione di una scrittura ben precisa ed assolutamente dalle qualità numeriche.