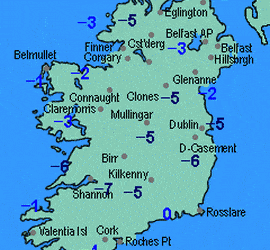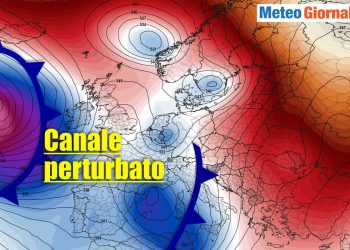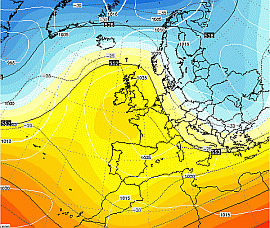Studiando il rapporto tra la l’equivalente di acqua, fornito dalla neve fusa, e la precipitazione totale in un dato periodo, basandosi sui dati storici di varie stazioni meteo alpine, si è potuto calcolare la percentuale di precipitazione nevosa che ricevono le Alpi a seconda della quota.
Per le vallate alpine più basse, solitamente sui 500 metri di altitudine, si è verificato che la percentuale di precipitazione nevosa è del 7% circa (Aosta 500 metri fornisce un dato del 13%). Queste si concentrano soprattutto in dicembre-gennaio, unici mesi che frequentemente offrono le ideali condizioni termiche che consentono la caduta della neve.
Salendo di quota passiamo a 1000 metri, dove il 21% dei fenomeni si manifesta sotto forma di nevicate. A questa quota i mesi più nevosi sono di più che in pianura ma sempre maggiormente concentrati nella stagione fredda.
A 1500 metri di quota il 35% dei fenomeni cade sotto forma nevosa, a 2000 metri la percentuale sale al 49%. Tra i 1500 e i 2000 metri si riscontrano 2 massimi di precipitazione nevosa concentrati in due periodi diversi, cioè tra novembre e dicembre e tra marzo e aprile; una riduzione delle nevicate si riscontra al culmine dell’inverno dove spesso prevalgono figure anticicloniche. A 2000 metri si assiste ai primi fenomeni nevosi estivi con accumuli al suolo che possono arrivare ai 5 cm e che si manifestano comunque molto raramente specie nel cuore dell’estate.
A 2500 metri, più della metà dei fenomeni precipitativi sono rappresentati da nevicate, con una percentuale del 63%; non certo insolite le nevicate estive anche se il massimo di apporti nevosi lo si ha in mesi distinti, cioè novembre e aprile. In estate si possono rilevare accumuli fino a 40 cm giornalieri con massimi al suolo di oltre 80 cm. Sono però frequenti gli anni senza nevicate estive.
A 3000 metri ormai i fenomeni sono praticamente quasi tutti in forma nevosa con la percentuale che raggiunge il 77%; le piogge si verificano soprattutto nei mesi estivi.
La quota dove la percentuale di precipitazione nevosa raggiunge mediamente il 100% si trova a 3700 metri.
Uno studio sulla piovosità attorno al Monte Bianco ha fatto ipotizzare che i massimi apporti di neve, sulla cima, si abbiano in piena estate dal momento che nelle zone circostanti, dove sono stati fatti i rilevamenti, le maggiori precipitazioni si hanno nei mesi estivi. Le cronache di scalate sulla vetta della montagna più alta d’Europa documentano forti tempeste estive portate da violenti temporali e forti tormente di neve.
Bibliografia
Atlante climatico della Valle d’Aosta – De Agostini Editore
Coefficienti nivometrici derivati da una ricerca di Pinna e Garzolo (1973)