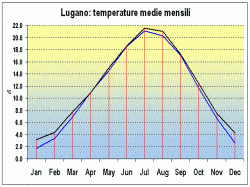La regione gravitante intorno ai bacini del Verbano, del Ceresio e del Lario, protetta a settentrione dall’arco alpino, è soggetta alla diretta influenza delle correnti padane, che vi subiscono una modificazione indotta dalla presenza dei laghi. Tale circostanza dà origine a un tipo di clima denominato insubrico (Spinedi, p. 82); lungi dall’identificarsi con la totalità geopolitica della Regio Insubrica, concerne solo le prossimità lacustri. Esso è ben rappresentato dalla stazione meteorologica di Lugano (273 m, WMO 06770), la cui serie, avviata nel novembre 1863 (Ferri, p. 30) e omogeneizzata dall’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera), risulta fondamentale per la storia dell’area.
Secondo la classificazione di Köppen il clima di Lugano rientra nella categoria Cfb (mesotermico umido con estate calda). Questo il quadro mensile, stagionale e annuo della norma statistica desunta dall’archivio 1864 – luglio 2008 (fra parentesi la deviazione standard):
| dicembre | 3,6 °C (1,3 °C) | 73,6 mm |
| gennaio | 2,3 °C (1,4 °C) | 62,3 mm |
| febbraio | 3,8 °C (1,7 °C) | 59,4 mm |
| inverno | 3,2 °C (1,1 °C) | 195,4 mm |
|---|---|---|
| marzo | 7,3 °C (1,6 °C) | 99,6 mm |
| aprile | 11,0 °C (1,2 °C) | 146,9 mm |
| maggio | 15,0 °C (1,5 °C) | 181,9 mm |
| primavera | 11,1 °C (0,9 °C) | 428,3 mm |
| giugno | 18,8 °C (1,4 °C) | 171,2 mm |
| luglio | 21,2 °C (1,3 °C) | 154,4 mm |
| agosto | 20,4 °C (1,2 °C) | 171,4 mm |
| estate | 20,1 °C (0,9 °C) | 496,9 mm |
| settembre | 17,1 °C (1,3 °C) | 163,3 mm |
| ottobre | 12,1 °C (1,3 °C) | 166,4 mm |
| novembre | 7,1 °C (1,1 °C) | 126,2 mm |
| autunno | 12,1 °C (0,9 °C) | 455,9 mm |
| anno | 11,6 °C (0,6 °C) | 1.575,1 mm |
Il regime pluviometrico può già definirsi di tipo alpino, poiché presenta il massimo durante l’estate; infatti, anche se maggio rimane il mese più piovoso, si nota l’assenza d’un massimo secondario autunnale (ottobre o novembre), il che lo esclude dalle caratteristiche del regime prealpino (Pinna, p. 460). Dal punto di vista termico va invece notata l’attenuazione dei calori estivi e dei rigori invernali dovuta all’effetto mitigatore del Ceresio; a questo proposito, le osservazioni indicano che l’acqua rimane più fredda dell’aria da febbraio ad agosto, mentre da ottobre a gennaio accade l’inverso, con scarto massimo ad aprile e minimo a dicembre (Ferri, p. 38). Tale caratteristica, unita alla limpidezza atmosferica per via delle frequenti situazioni favoniche, connota la regione come Sonnenstube (salotto del sole) e permette, non solo a Lugano (Locarno Monti, Magadino), di avvicinare, o superare, le 2.000 ore di soleggiamento annuo.
La scomposizione dell’archivio meteorologico di Lugano può, per comodità, avvenire in gruppi di 18 anni; la seguente sintesi, riguardante temperature e precipitazioni medie annue, per quanto arbitraria, dà già conto del notevole incremento termico intervenuto a cavallo del XXI secolo:
| 1864-1881 | 11,5 °C | 1.501,8 mm |
| 1882-1899 | 11,2 °C | 1.639,3 mm |
| 1900-1917 | 11,2 °C | 1.608,8 mm |
| 1918-1935 | 11,5 °C | 1.634,5 mm |
| 1936-1953 | 11,8 °C | 1.536,9 mm |
| 1954-1971 | 11,5 °C | 1.563,5 mm |
| 1972-1989 | 11,7 °C | 1.616,9 mm |
| 1990-2007 | 12,7 °C | 1.487,5 mm |
L’omogeneità climatica della regione è un riflesso della continuità geografica, da cui discende l’unità linguistica. Fra i termini caratteristici indicanti fenomeni meteorologici, in uso sia nel Canton Ticino che nelle aree limitrofe, si segnalano, per frequenza, buzza (piena dei corsi d’acqua) e breva (brezza di lago).
Bibliografia:
G. FERRI, Il clima di Lugano nel cinquantennio 1864-1914, «Bollettino della Società Ticinese di Scienze Naturali», a. IX-X, n. unico (1915), pp. 29-52.
M. PINNA, L’atmosfera e il clima, Torino, 1978.
F. SPINEDI, Il contributo delle stazioni meteorologiche secondarie della Svizzera Italiana per la storia del clima locale, con accenni di climatologia generale del versante Sudalpino, in L. BONARDI (a cura di), Che tempo faceva?, Milano, 2004, pp. 79-89.