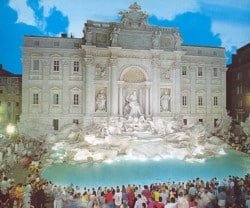Tolta la polvere dai libri d’epoca, mi rendo conto che anche io parlo troppo spesso di clima che si sta estremizzando, senza cercare degli esatti punti di riferimento con 50 o 100 anni fa.
Finalmente torno sul Meteo Giornale presentando anche ricerche sul Clima del passato, per meglio comprendere quello attuale e poter discutere con maggiore competenza gli articoli che tutti giorni scrivo.
Da appassionato di dati storici, posseggo una collezione di pubblicazioni e sovente rilevo che i dati indicati in un tal testo, poi vengono smentiti da un altro. Mi riferisco a valori termici estremi. Questo crea delle difficoltà e comunque ne parleremo passo, passo.
Un grande aiuto l’ho avuto nei testi del grande Mennella ed il suo staff.
Mennella fa parte di una serie di scienziati padri della meteorologia e climatologia italiana, che con passione e umiltà compilavano pubblicazioni oggi irreperibili. Scrivevano i loro dubbi e perplessità sull’esito delle loro ricerche, non erano soggetti alle ansie degli odierni scienziati.
La mia non intende essere una critica, ma una seria riflessione, in quanto dalle letture di varie pubblicazioni mi rendo conto che facevano questo lavoro con passione estrema, senza cercare lodi o audience (manco si usava questo termine), dicendoti alla fine della ricerca che potevano aver sbagliato ed anche il motivo dei loro dubbi.
Ti insegnavano a capire. Penso che questa lezione di umiltà serva a tutti noi.
Le ricerche sulla temperatura estrema massima di circa cento anni fa, possono avere una delicata utilità perché troppo spesso si lanciano sensazionalismi sulle temperature odierne, sempre pur riconoscendo che la temperatura del Pianeta è in aumento e che si stanno manifestando troppo spesso eventi che prima avvenivano ad intervalli temporali più ampi.
I dati censiti li abbiamo accorpati per macro aree climatiche, ma dobbiamo citare da subito alcune esagerazioni, per altro confermate da altri rilevamenti dell’epoca. Può darsi che talune stazione di rilevamento non fossero a norma, ma questo è un argomento assai delicato che tocca anche i rilevamenti dei giorni nostri, con strumentazione che costano anche 50.000 Euro soggette a scarsa manutenzione e da cui si ricostruisce il clima dell’Italia.
Il Mennella cita i notevoli massimi di Treviso, 39,2°C, un valore sorprendente. Lascia traccia di un picco massimo relativo a Roma con +42,5°C, mentre appare incredibile il dato di Palermo che il 29 agosto 1885 ebbe ben 49°C.
Le temperature più elevate nel corso dell’estate si hanno con pressioni livellate o con invasioni di aria sub-tropicale, che influenzano soprattutto la Sicilia e l’Italia Meridionale. In media tali situazioni si ottenevano tra la terza decade del luglio e la prima di agosto.
Va detto che da qualche anno queste situazioni non si manifestano in tal modo, ma non è detto che sia solo una semplice fluttuazione climatica.
Ma ecco gli estremi del primo trentennio del ‘900, con valori espressi in gradi centigradi:
Regione Alpina: Aosta 38,0, Domodossola 43,0, Bergamo 38,0, Breno 35,5, Grono 36,0, Bolzano 38,1, Trento 40,4, Belluno 38,4, Claut 35,0, Tarvisio 38,0.
Valle Padana: Cuneo 37,5, Torino 42,6, Bra 39,4, Asti 39,4, Alessandria 39,5, Ivrea 45,0, Spigno Monferrato 40,0, Bologna 39,6, Cremona 38,4, Mantova 43,2, Parma 40,0.
Regione dei Laghi: Bellano 37,7, Varese 37,0, Bergamo 38,0, Brescia 38,4.
Versante Padano dell’Appennino: Montalto Pavese 37,0, Canossa 37,0, Porretta Terme 38,0, Firenzuola 38,9, Rocca S. Casciano 39,0.
Versante Adriatico Settentrionale: Trieste 37,0, Udine 36,9, Verona 38,0, Vicenza 39,3, Cologna 40,0, Padova 39,0, Rovigo 39,0, Alfonsine 39,4, Classe 39,4, Cesena 40,0.
Marche e Abruzzo: Mercatello sul Metauro 38,2, Bargni 39,4, Fabriano 40,0, Iesi 40,2, Ornano 40,0, Ascoli Piceno 42,5, Fermo 39,5, Teramo 40,5, Pescara 43,0, Chieti 40,0, Scernì 41,0, Larino 41,1, Campobasso 40,0.
Puglia: Foggia 42,1, Cerignola 45,8, San Severo 46,6, Bari 41,9, Andria 43,5, Altamura 43,3, Locorotondo 40,0, Matera 42,0, Valsinni 42,5, Melfi 42,2, Castellaneta 43,5, Manduria 44,1, Taranto 39,2, Metaponto 43,2, Brindisi 400,5, Lecce 42,8, Presicce 40,7.
Liguria: Airole 37,2, Stella S. Bernardo 37,5, Isoverde 37,6, Genova 37,0, La Spezia 38,8.
Toscana: Pistoia 40°,3, Suvereto 39°,1, Pisa 39°,5, Lucca 39°,5, Firenze 40°,5 Borgo S. Lorenzo 41°,6, Prato 41°,0, Empoli 43°,5, Arezzo 39°,6, Grosseto 41°,5, Massa Marittima 40,0.
Umbria: Gubbio 40,0, Orvieto 42,5, Terni 40,6.
Lazio: Tuscania 42,5, Subiaco 39,0, Roma 40,0, Velletri 40,0, Latina 39,0, Gaeta 38,8.
Campania: Benevento 38,8, Caserta 40, Salerno 38,9.
Calabria: Cosenza 43,7, Fagnano C. 43,0, Tropea 40,5, Reggio 41,0, Rossano 43,3, Crotone 44,5, Catanzaro 39,3, Caulonia 41,7.
Sicilia: Tindari 40,2, Palermo 42,0, S. Giuseppe Iato 40,7, Trapani 40,0, Sciacca 42,0, Agrigento 39,5, Corleone 41,3, Bidona 42,0, Caltanissetta 41,6, Ragusa 41,0, Enna 43,4, Catania 44,3, Siracusa 43,5, Caltagirone 40,0. (Ma a Palermo, il 29 agosto 1885, con vento di scirocco ed effetto di foehn, venne registrata una temperatura di ben 49°C).
Sardegna: Santa Giusta 42,8, Cagliari 40,3, Iglesias 45,0, Sassari 41,0, Busachi 41,5, Mandas 40,5, Macomer 42,2, Olbia 40,1, Orosei 40,5, Armungia 40,3, Tempio Pausania 40,3, Nuoro 40,0.
Fascia Assiale Appenninica: Scanno 39,5, Roccacaramanico 38,0, Montazzoli 39,0, Monte S. Angelo 38,0, Potenza 38,2, Teana 41,1. Stigliano 33,6.
I valori più elevati, superiori ai 43 gradi, sarebbero quelli di Domodossola nella Regione Alpina; di Ivrea e di Mantova nella Valle Padana; di Pescara nell’Abruzzo; di Cerignola, San Severo, Andria, Altamura, Castellaneta, Manduria in Puglia; di Empoli in Toscana; di Metaponto nella Basilicata; di Cosenza, Fagnano, Rossano, Crotone in Calabria; di Enna, Catania, Siracusa in Sicilia; di Iglesias in Sardegna.
Ovviamente non si esclude che possano esistere altre località con massime assolute ugualmente elevate. Non viene citato per il periodo il dato di Milano, ma avremo maniera di analizzare meglio questi dati.
Nel corso del ‘900, varie città che abbiamo citato nell’articolo, hanno avuto picchi estremi assai maggiori, inoltre il Mennella prende in esame i mesi di luglio e agosto, incorrendo a qualche errore quindi nel definire gli estremi di caldo del trentennio.
In un’altra pubblicazione, la città di Sassari vediamo che ebbe una massima di +45°C il 6 settembre. Ma ancora, in una pubblicazione di cui non rammento l’autore, si menziona un picco di +48.5°C nel 1908 a Messina.
Orbene, ci lasciamo con questi dubbi, nell’augurio di averVi offerto un’occasione di lettura dilettevole.