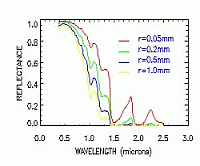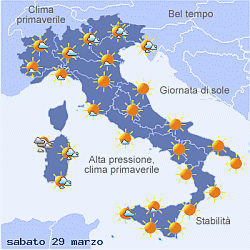La natura altamente riflettiva della neve combinata con l’enorme copertura (la neve può infatti coprire più del 40% della superficie terrestre durante l’inverno boreale) fanno sì che la stessa sia un importante componente del bilancio radioattivo terrestre.
E’ ormai noto che la neve influenzi in maniera cospicua i processi biologici, chimici e geologici del nostro pianeta. Senza considerare che parecchie aree nel mondo vengono approvvigionate idricamente dallo scioglimento diretto delle nevi e altre spesso sono a rischio di inondazione sempre per il fenomeno del disgelo primaverile.
Le precipitazioni nevose nascono dall’opportuna condensazione del vapor d’acqua a temperatura inferiore lo 0°C. Dunque la neve può cadere sia sotto forma di singoli cristalli (quelli esagonali molto scenici) o in agglomerati di cristalli (fiocchi) più o meno umidi. Successivamente a seconda della temperatura può trasformarsi in pioggia oppure depositarsi in accumuli. Appena caduta la neve inizia modificarsi per metamorfismo e i cristalli si decompongono in frammenti i quali a loro volta, col passare del tempo e grazie al peso della neve sovrastante, crescono di dimensioni fino a unirsi gli uni con gli altri assumendo una forma quasi sferica. Spesso la neve si trasforma in ghiaccio sotto le medesime condizioni.
Una caratteristica particolare della neve è costituita, come abbiamo già accennato, dalla capacità di riflettere fino l’80% dell’energia proveniente dal Sole, tale proprietà viene misurata dall’Albedo.
Studiare da satellite la copertura nevosa di una zona è relativamente semplice grazie proprio alla albedo elevata che la neve presenta e al buon contrasto che la contraddistingue dalle altre superfici naturali. Fanno eccezione le nuvole (in particolare i cirri) con le quali spesso si può confondere senza l’ausilio alcuni accorgimenti.
Iniziato con il satellite TIROS-1 e proseguito con l’AVHRR dei NOAA e il TM del LANDSAT il telerilevamento di tutte le aree interessante da nevi e ghiacci consta attualmente di numerosi sensori in grado di garantirne un monitoraggio continuo.
Vediamo dunque di analizzare sommariamente alcuni algoritmi più comuni per il nostro scopo. Osservando la curva di riflettanza della neve si nota come presenti 2 picchi di assorbimento attorno a 1.4 e 2 micron mentre nel visibile (0.5 micron) raggiunga valori prossimi all’unità.
Tale andamento viene sfruttato dal NDSI (Normalized Difference Snow Index) inteso come il rapporto tra le differenze di radianza a 0.5 e 1,6 e la loro somma.
Se l’NDSI ha valori superiori a 0.4 è possibile stabilire con certezza quali pixel sono interessati da una copertura nevosa superiore al 50%. In realtà spesso pure gli specchi d’acqua mostrano valori simili ma la riflettanza minore dell’acqua nel visibile garantisce l’univocità del rilevamento.
Tale indice permette inoltre la discriminazione con la maggior parte delle nuvole che a prima vista potrebbero essere scambiate per zone coperte di neve.
In ausilio dell’indice di neve spesso di adopera pure l’indice di verde (NDVI) per monitorare la copertura nevosa sulle foreste e sulle aree vegetate così da studiarne l’andamento in prossimità del disgelo.
Le immagini da qui elaborate vengono successivamente unite per formare delle mappe a varie risoluzioni spaziali e temporali al fine di acquisire maggiori informazioni possibili sull’andamento ciclico delle stagioni nevose. Un esempio viene fornito gratuitamente dalle mappe elaborate dal sensore MODIS a bordo dei satelliti AQUA e TERRA così come visibile in figura 2.