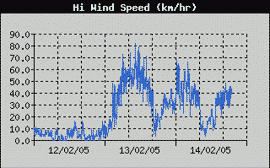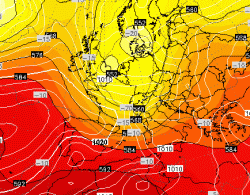Sabato 12 febbraio 2005, ai piedi delle Alpi occidentali è una tranquilla e mite giornata invernale, nulla lascia presagire un cambiamento atmosferico. Ma il föhn si sta accingendo, se ne accorge il barometro che precipita di quasi 1hPa all’ora (fig. 1). È imminente un nuovo episodio di föhn, portatore di aria mite e secca, un ultimo affronto alla poca neve rimasta. Dalla notte ai piedi delle montagne il vento soffia oltre gli 80Km/h, con temperature oltre i 13°C. Sui versanti esposti al sole la neve è ormai assente fino oltre i 2300m.
Nel frattempo i media tuonano vortici polari che trasportano aria freddissima. Si parla di temperature polari, neve, gelo. Vero, ma solo al Sud Italia. Occorre quindi una descrizione del fenomeno non di tipo generale, ma mirata alla singola realtà locale. Cerchiamo di farlo qui di seguito, rammentando al lettore che non si vuole dare una spiegazione esaustiva e dettagliata, ma limitata ad una sintetica descrizione dei complessi fenomeni in gioco.
Cominciamo con un’analisi della situazione atmosferica globale. Durante l’ultimo mese più volte l’anticiclone delle Azzorre, presente in maniera a volte anomala sul continente europeo occidentale, ha spinto la propria influenza verso N, ma senza abbandonare il Mediterraneo centro-occidentale. Questo ha provocato una discesa di aria fredda in quota verso i Balcani. Come se non bastasse, l’alta pressione atlantica si è più volte congiunta con una propaggine dell’anticiclone russo sul Baltico, isolando l’aria fredda precedentemente trasportata sui Balcani, l’Adriatico e l’Egeo dove si invortica in un minimo depressionario. È quanto si sta nuovamente verificando.
Tutto questo accade in quota, ed è quanto viene ad esempio analizzato dalle carte a 500hPa, ovvero ad una altezza di circa 5000m. Aria fredda in quota indica la presenza di bassa pressione, quindi venti vorticosi che mescolano l’aria e consentono all’aria più mite si salire e condensare nelle precipitazioni. Questo è quanto accade al Sud Italia, dove si forma un minimo depressionario al suolo: grazie ai moti convettivi verticali l’aria fredda con le precipitazioni raggiunge anche il suolo, le temperature diventano rigide e nevica.
Al Nord Italia in inverno quando transitano vortici polari le cose vanno diversamente. L’aria fredda trasportata a tutte le quote a N delle Alpi viene nei bassi strati in gran parte fermata dalla catena montuosa. Qui produce precipitazioni per effetto stau (termine tedesco che significa “sbarramento”). Oltre la catena alpina, sui versanti italiani, l’aria fredda non riesce a trasmettersi nei bassi strati (o lo fa molto marginalmente). L’accumulo di aria fredda a ridosso della montagna ha, localmente, l’effetto di aumentare la pressione al suolo rispetto all’altro versante (il nostro) dove l’aria resta più mite e leggera (bassa pressione al suolo). Si origina così il caldo vento di föhn. Oltre all’effetto di accumulo di aria fredda e umida sul versante sopravento, il föhn si riscalda sul versante sottovento anche per effetto del gradiente adiabatico secco contrapposto a quello dell’altro versante alpino dove è umido. Questa dinamica porta sui versanti soggetti a föhn ad un diverso comportamento dell’aria nei bassi strati rispetto a quella negli alti strati. Mentre le vette alpine ed i versanti esteri vedono un forte raffreddamento con umidità crescente, sui versanti italiani si ha un riscaldamento nei bassi strati con umidità relativa che può scendere sotto il 10% ( vedere fig.1).
Il föhn è un fenomeno a retroazione positiva: più il vento si riscalda sottovento e si raffredda per stau sopravento, più aumenta il divario termico e quindi barico tra i due versanti della catena alpina, aumentando di conseguenza la velocità del vento stesso – il vento, lo si ricorda, è infatti uno spostamento di massa d’aria da una zona di alta pressione ad una di bassa pressione.
La presenza del vento inibisce in parte la reirradiazione anche con cielo sereno: non c’è perdita di calore durante la notte, analogamente a quanto accade quando il cielo è nuvoloso. Un altro fattore che, indubbiamente, contribuisce marginalmente a tenere elevate le temperature.
Al piano la temperatura comincia a scendere quando l’afflusso di aria fredda da Nord termina, per reirradiazione notturna consentita dal placarsi del vento. Anche se le diminuzioni possono ancora essere sensibili (ma solo in alcuni casi), nulla hanno a che vedere con le temperature che si sarebbero avute in assenza del fenomeno del föhn.
Naturalmente i termini föhn e stau sono relativi al punto di vista da cui si intende analizzarli. Dal nostro punto di vista (italiano) parliamo quindi di föhn da N, W o NW (stau sui versanti esteri delle Alpi) e stau da S, E, SE (föhn sui versanti esteri delle Alpi), dove i punti cardinali indicano la direzione di provenienza del vento.
Anche se sovente quando transita un vortice polare si accende una certa enfasi nelle comunicazioni, nel mondo dei meteorofili in particolare, questo tipo di tempo è del tutto normale in inverno, soprattutto a febbraio, e lo è ancor di più in primavera. Lo è un po’ meno in maniera ripetuta e continua, come accade negli ultimi anni. Si legga a tal proposito l’articolo di Andrea Meloni, un’ottima, equilibrata sintesi di quanto sta avvenendo nell’ultimo decennio: www.meteogiornale.it/news/read.php?id=10274
Il vortice polare sull’Italia settentrionale può avere anche un altro effetto. Se l’aria fredda dal Polo discende verso la Valle del Rodano o comunque a ovest delle Alpi si origina un richiamo di aria umida e mite da sud. La mancanza dell’effetto föhn consente la formazione di precipitazioni. Tali precipitazioni possono risultare nevose anche in pianura, grazie alla perdita di aria calda insita nei moti convettivi dell’aria dovuti alle precipitazioni. Ma al suolo non si hanno mai temperature molto basse, spesso anzi la neve cade con temperature prossime o sopra lo zero (si veda ad esempio il caso del 28 febbraio 2001).
Concludendo il vortice polare sull’Italia settentrionale è sovente mite, o per effetto föhn, oppure per il richiamo di aria da sud.
Quindi quali sono gli inverni che portano neve e gelo al Nord Italia? Cosa succede se l’anticiclone abbandona il Mediterraneo centro-occidentale?
Occorre per questo una classica configurazione dell’anticiclone russo-siberiano, figura un tempo dominante negli inverni italiani, ma negli ultimi 10-15 anni in forte ripiego. L’anticiclone russo stabilisce un tempo secco e piuttosto freddo – ed infatti i mesi invernali al Nord Italia sono i più siccitosi. Tuttavia imponendo venti orientali non consente la formazione del föhn. Con i venti orientali inoltre la Pianura Padana si trova in una situazione invertita rispetto a quella del föhn: ora lo stau può episodicamente verificarsi sui versanti italiani presso le Alpi occidentali. Quindi l’aria fredda si addensa nei bassi strati. Infatti sulle vette alpine le temperature sono in alcune circostanze più rigide quando c’è föhn da N che quando avviene stau da E con gelo sulle pianure.
Accade a volte che l’anticiclone russo possa ritrarsi e consentire il passaggio di un fronte atlantico, che grazie al cuscinetto freddo nei bassi strati porta neve in pianura. È il caso ad esempio del 1995, quando nevica più di venti volte a Torino.
Ma la neve con temperature basse – e molto abbondante! – avviene in genere diversamente, quando l’anticiclone russo impone un flusso antizonale (da Est verso Ovest). L’aria fredda entra nel Mediterraneo dalla porta della bora, nei bassi strati più che in quota, e innesca una vortice sulla Pianura Padana. L’ultimo caso lo abbiamo avuto nel dicembre 2001. Se i venti da Est non sono sufficientemente intensi o umidi non sempre si genera una depressione, e molto spesso è limitata agli istanti iniziali dell’avvezione fredda.
In sintesi, il gran freddo con la neve al Nord Italia non si ha grazie ai quei miti vortici polari, ma con depressioni mediterranee alimentate da aria fredda proveniente da Est!
Ricordiamo ad esempio i casi intensi ed anomali del 1986 e 1987, quando tali depressioni portano più di 40cm nel Torinese. Nel 1986 a causa dello stau intenso sulle Alpi Graie l’accumulo della neve supera, localmente, addirittura i 2m.
È possibile ipotizzare, ma è discutibile, un perché alla debolezza dell’anticlone russo-siberiano. Si tratta di un anticiclone termico, ovvero si origina al suolo per via dell’aria molto fredda che ristagna nei bassi strati sulle pianure dell’Europa orientale, della Russia e della Siberia. Se manca il freddo, manca anche l’anticiclone russo.
Con questa breve digressione si spera di aver chiarito alcuni fenomeni locali frequenti nelle nostre regioni. Invito sempre il lettore a leggere ogni affermazione e previsione interpretandola a livello locale. In questi giorni, e nei prossimi, ad esempio si parlerà di nuovo di freddo intenso e temperature da brivido in alta quota. Ma per la presenza del vortice polare con minimo depressionario sull’Adriatico e sullo Ionio: quindi freddo intenso al Sud Italia e non sulla Pianura Padana.
L’inverno meteorologico, che pone il suo termine al 28 febbraio, è dunque destinato a chiudersi in maniera mite anche quest’anno? Ho più volte scritto nelle analisi ensemble che un inverno è probabile che finisca con le stesse configurazioni con cui inizia. Ma questa volta potrebbe esserci un’eccezione, sia pur proprio pochi giorni prima del termine meteorologico dell’inverno.
In alcune circostanze l’Anticiclone Atlantico può fare le veci della più fredda alta pressione russo-siberiana. Succede a volte che l’Anticiclone delle Azzorre si posiziona sull’Inghilterra e sui paesi baltici, lasciando in relativa bassa pressione o ristagno barico l’intero Mediterraneo centro-occidentale. Fatto che quest’anno non è mai avvenuto. I venti si dispongono così da Est sulla Pianura Padana, di provenienza russa o baltica, trasportati finalmente a bassa quota dalle gelide pianure continentali. Tale configurazione non è stabile, ed in genere perdura per pochi giorni. Ma se all’alta atlantica si congiunge con un ponte da est l’alta russa-siberiana (asse di Woejkoff), allora la situazione atmosferica può stabilizzarsi maggiormente.
Le stime a lungo termine (ENS GFS dell’NCEP) promuovono questo tipo di tempo verso fine mese, quando il vortice polare viene confinato addirittura sulle isole Svalbard. Attendiamo quindi conferme per le previsioni locali di questa fine d’inverno che potrebbe curiosamente coincidere con il suo momento più freddo, forse in termini assoluti, sicuramente in relazione alle medie stagionali. Tutto questo, in ogni caso, non prima del 24/25 febbraio.