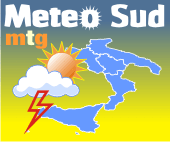Non è facile immaginare quello che può essere l’impatto globale di un’eruzione vulcanica di dimensioni gigantesche, alle quali, in tempi storici, non siamo stati minimamente abituati.
L’unico termine di paragone che abbiamo, è quello fornito dalle due grandi eruzioni del XIX Secolo, quelle del Monte Tambora e quella del Krakatoa.
Di quest’ultima, avvenuta nel 1883, abbiamo testimonianze di molti scienziati e geologi dell’epoca, si stima che vennero immessi nell’atmosfera terrestre circa 20 km cubici di materiale, tra rocce polverizzate, ceneri, e solfati.
Una volta giunge nell’atmosfera, tali particelle, trasportate dalle grandi correnti in tutto il globo, hanno contribuito ad abbassare la temperatura terrestre, forse di 4-5 decimi di grado centigrado, oltre a determinare altri effetti particolari (le “nubi nottilucenti” formatesi in seguito alle particelle entrate nella stratosfera illuminarono a giorno Londra nel mese di Agosto, in piena notte).
Il Monte Tambora, sempre in Indonesia, esplose nel 1815, eiettando un quantitativo di materiale che si stima essere stato il doppio di quello emesso dal Krakatoa.
Difficila stabilirne gli effetti globali, visto che le misurazioni delle temperature terrestri non erano precise come adesso, e visto anche che già eravamo in uno dei decenni più freddi della “Piccola Età Glaciale”.
Tuttavia, un calo di 0,7-0,8°C della temperatura della Terra indotto dall’eruzione non sembra utopico, vista la presenza di nevicate nel mese di Giugno 1816 sulle coste nord americane, e la “mancata estate”, sempre del 1816, in Europa (Parigi registrò temperature di 2-3°C inferiori alla norma per tutti e tre i mesi più caldi dell’anno).
Il Pinatubo, nel 1991, eiettò soli 10 km cubici di materiale, ma questo sembra esser stato sufficiente per bloccare temporaneamente la risalita termica degli ultimi anni, abbassando di 0,1-0,2°C la temperatura globale.
Le particelle di solfati emesse dalle eruzioni, infatti, riflettono la radiazione solare comportandosi come “specchi”, impedendone il raggiungimento della superficie terrestre, e provocando un ovvio calo termico.
Tuttavia, spesso tali eruzioni si inseriscono all’interno di oscillazioni naturali del clima terrestre, per cui valutarne la portata a livello globale risulta essere abbastanza difficile.
Si è detto dell’eruzione del Tambora, il raffreddamento provocato sull’Emisfero Settentrionale determinò il “mancato Monsone Indiano” di quell’anno, con effetti devastanti sulla popolazione locale, tuttavia il fenomeno si inserì al culmine di un periodo di raffreddamento già iniziato da almeno un decennio (forse l’anno più freddo in assoluto fu il 1812), mentre non tutti ricordano che, dopo la terribile estate fredda del 1816, i due inverni successivi furono al contrario molto miti.