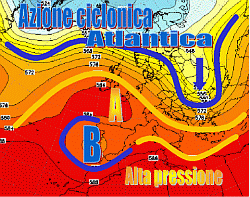Diamo per certo, quasi fosse un postulato, l’aumento smisurato delle emissioni di origine antropica che si riferiscono ai gas “effetto serra”. Sposiamo tutte le tesi, empiriche o meno, circa un riscaldamento globale.
Ma è l’unico elemento certo, acquisito ed incontrovertibile, circa le variazioni osservate negli ultimi dieci, venti anni?
Sicuramente l’interazione fisica di questi gas è ben riconosciuta da molti scienziati ed il ruolo che essa riveste è determinante circa le variazioni climatiche del nostro Pianeta (tralascio volontariamente l’aspetto principale, fonte di ogni origine).
Come accennato in precedenti editoriali, la stesura dei modelli climatici, onnicomprensivi, è ancora ben lontana dal determinare le cause effettive di questo lungo processo; meglio: non esistono ancora processi certi che possono essere facilmente ricondotti e compresi , nella loro oggettiva valutazione, negli stessi complessi modelli climatici.
Ciò potrebbe significare che in un futuro, non molto lontano, vengano rivisti (rivalutati) i meccanismi di feedback i quali potrebbero anche indicare, sorpresa di molti, un netto ridimensionamento circa gli effetti causati dalle attività umane.
Tuttavia, va segnalato come le principali “retroazioni” di origine umana siano tutte rivolte verso un “feedback” positivo.
Nell’ultimo decennio, tuttavia, molti di questi meccanismi sono stati considerati in maniera molto più attenta: basta pensare al ruolo determinate che le oscillazioni ENSO hanno sulla variabilità interannuale del clima sul nostro Globo; inoltre analisi molto più attente e capillari sono state fatte circa il ciclo medio del carbonio che agisce sul terreno e sulla superficie degli oceani.
Molte correnti di pensiero, in base all’introduzione di questi nuovi elementi, sembrano aver intercettato un “punto oscuro”: il ruolo delle copertura nuvolosa nei cicli di feedback e l’influenza che il CO2 può arrecare circa la loro maggior o minor formazione (nuclei di condensazione).
A questo punto, teorizzando, sembra che l’impatto umano sia una delle minor cause circa un riscaldamento, che in assoluto, non può essere rivisto esclusivamente verso l’alto.
Qui bisognerebbe fare un punto, impossibile al momento nel suo reale test, e riguardante la quantità di energia solare, tramite una maggior copertura nuvolosa, che è in grado di assorbire una nube e quale è il giusto bilanciamento inerente al calore che possono trattenere le nubi dalla terra (effetto serra).
La proporzione dovrebbe, secondo alcuni climatologi, essere a favore dell’energia solare assorbita dalle nubi; quindi riscaldamento rivisto verso il basso.
In tutto questo contesto, l’impegno dei modelli climatici (privi di enfasi di qualsiasi genere) dovrebbe essere quello di rendere ancora più sofisticato, inglobando una serie molteplice di casi, onde avvicinarsi il più possibile ad un punto iniziale.
In questo contesto si dovrebbe meglio intravedere la naturale e caotica espressione del sistema globale di previsione; ciò cogliendo le sfumature e gli errori, talvolta forniti per motivi che non è il caso di citare, al fine di riportare il tutto verso un’analisi delle zone e dello spazio onde procedere all’individuazione di variabili che divergono in maniera esponenziale: i così detti “punti di biforcazione”. Origine dove una tendenza climatica si apre e si sviluppa in maniera “ramificata”; quindi poco leggibile e molto caotica.
Il frutto di molti “happening” evolutivi sta proprio in questa mancata riconduzione all’origine, seguendo una forbice molto stretta, di tale modello.
Se si mostra aperto, in esso inevitabilmente confluiranno dati discordanti che indicano, a fasi alterne, quale è il “presunto”, ma non certo, processo circa un cambiamento climatico.
Mentre nella meteorologia, dove lo scopo è quello di una previsione il più deterministica circa l’evoluzione di una stato futuro (breve), queste biforcazioni portano ad una marcata impredicibilità dopo un certo lasso di tempo, nell’osservazione del clima, in scala numerica, esse concludono il sistema stesso su classi (evoluzioni) il cui stato si mostra “possibilista” e la cui maggior componente è riferibile alla statistica.
Potremmo più semplicemente sintetizzare ciò come: mentre nella meteo tali “biforcazioni” si subiscono, nello studio del clima queste hanno tutte le prerogative per essere sfruttate onde determinare una scadenza climatica e statistica più completa ed estesa durante un ampio percorso temporale.